Sorvolare con le mani un mappamondo, lasciarsi sedurre dall’azzurro dell’Oceano, ora blu ora celeste, circumnavigare con le dita le sinuose coste dei continenti, e poi planare con gli occhi su un’isola minuscola e sperduta. Non esiste un atto letterario più seducente e più sensuale di questo. Lo sapeva bene Stevenson che disegnò la sua isola, perché ogni storia scaturisce da un’immagine, e l’Isola è un’immagine potentissima.
Le carte geografiche non sono solo strumenti utili per viaggiare, sono molto di più. Saper guardare gli atlanti è un’arte che porta lontano, un’arte che apre gli spazi attraverso gli spazi, un’arte che apre le porte dell’immaginazione nel vasto oceano del divenire. Il più impavido alchimista sa bene che per imbastire le parole giuste è necessario impastarle con gli elementi del nostro pianeta, e poi lavorarci su per creare nuovi mondi, o storie. Ai più grandi avventurieri della penna, ai più audaci visionari, poco importava se le mappe di allora erano approssimative, quello che contava davvero era vederle coi propri occhi interiori.
L’atlante è l’unico libro muto che ci dice continuamente che siamo tutti stranieri e tutti fratelli e che siamo in qualche modo legati dalla curiosità di conoscerci, di scoprirci, di approfondirci.
L’Atlante delle isole remote di Judith Schalansky è uno scrigno di meraviglie. Appaiono d’incanto, ora dietro una fitta cortina di nebbia, ora dietro un accecante sole tropicale, una dopo l’altra, cinquanta isole talmente sconosciute che sembrano poter esistere solo in una dimensione in bilico tra sogno e realtà. Luoghi inaccessibili e remoti, impervi e ardui all’approdo, luoghi difficili da trovare, perché basta una nuvola o un’onda per farli sparire all’orizzonte. Siano esse terre paradisiache o inospitali, sono comunque luoghi ai confini del mondo. Microcosmi scorporati dai continenti, lingue di sabbia remote e indipendenti, nere scogliere battute da tempeste perenni, le isole hanno un ritmo proprio: il clima, la fauna, la vegetazione, tutto è avulso da ogni contesto.
L’autrice stila didascalie sui generis, miscelando tra loro eventi storici e leggende indigene, naufragi e accidenti. Ogni isola ha una sua storia, una storia aperta, una storia sensibile ai venti e all’occhio nuovo che la osserva. I racconti sono suscettibili di cambi di scena, cambi di costume, ribaltamento di prospettiva, qualcosa di antico e perduto ritorna, qualcosa di indecifrato e incomprensibile resta. Le isole sembrano avere lo stesso potere del teatro. Mettono in scena i mondi dei mondi, con quel che si trova, con quel che la risacca è riuscita a lasciare sulla spiaggia, l’albero divelto di un galeone, un baule pieno di monete d’oro, una palla da basket, l’elica di un aeroplano, una lattina di coca-cola. Ma il loro spettacolo è unico e irripetibile.
Così, al di là degli avventurieri, dei diari, dei tesori, delle scoperte, degli scienziati, degli ammutinamenti, delle conquiste, delle stazioni meteo, delle antenne e degli esperimenti nucleari, accade persino che le isole ci scelgano e viaggino attraverso l’incantato oceano onirico per insegnarci la loro lingua. Accade, che la maglia invisibile di paralleli e meridiani nasconda scorciatoie misteriose che non siamo ancora in grado di decifrare, disegnare. Accade, che un idioma faccia da ponte tra due continenti, fra un uomo e un’isola, fra un uomo e una donna. È il caso di Rapa Iti, un’isola della Polinesia francese. La storia è questa: “In una piccola città situata nelle propaggini dei Vosgi, un bambino di sei anni è tormentato da un sogno ricorrente nel quale qualcuno gli insegna una lingua completamente sconosciuta. Ben presto il piccolo Marc Liblin non la parla più fluentemente soltanto in sogno, pur senza sapere da dove venga o se esista davvero. Marc è un bambino solo, molto dotato e assetato di sapere. Da adolescente divora più libri che pane. All’età di trantatrè anni vive appartato dal mondo, in Bretagna. Qui, alcuni ricercatori dell’Università di Rennes lo notano, vogliono decifrare la lingua dei suoi sogni e tradurla. Per due anni alimentano i loro enormi calcolatori con gli strani suoni di Marc. Inutilmente. Un giorno, i ricercatori hanno l’idea di andare per i bar del porto a chiedere ai marinai in libera uscita se qualcuno di loro abbia già sentito quella lingua da qualche parte. In un’osteria di Rennes, Marc Liblin si esibisce in un assolo, monologando davanti a un gruppo di tunisini. A un certo punto l’uomo dietro il banco, un ex appartenente alla marina, si intromette e dichiara che ha già sentito una volta questa parlata, sulla più solitaria di tutte le isole della Polinesia. E conosce un’anziana signora, la moglie divorziata di un militare, che abita in una casa popolare di periferia e che parla proprio in quel modo. L’incontro con la signora polinesiana cambia la vita di Liblin: Meretuini Make apre la porta, Marc la saluta nella sua lingua e lei risponde subito nell’antico Rapa della sua terra. Marc Liblin, che non ha mai lasciato l’Europa, sposa la sola donna che lo capisce e nel 1983 parte con lei per l’isola dove si parla la sua lingua.”
Ogni isola ha la sua lingua. La sua forma. La sua fortuna. Le isole stesse sono un alfabeto ulteriore, per chi da ultraterrene distanze spaziali riesce a leggerle e a raccontarcele. Quello che sorprende, per chi le visita davvero e se ne fa assorbire, è la totale inutilità di una possibile traduzione. Le isole sono contenitori che distillano sentimenti purissimi, non traducibili. Come la nostalgia di Brava, isola di Capo Verde, che si ammanta di strazianti melodie per una patria che non esiste e che non è mai esistita. O come l’infinita solitudine di Tromelin, un’isola di ottocento metri per due chilometri, in mezzo all’Oceano Indiano, che liberò gli schiavi in una condizione ancor più paradossale di prigionia.
Ci si perde. Si naufraga. Sfogliando l’atlante di Judith Schalansky non si ha sosta. Anche quando l’autrice finisce col descrivere l’ultima minuscola porzione di terra, anche quando compare l’elenco con le sue coordinate geografiche, anche lì, la sensazione è quella di non aver letto tutto, di dover tornare indietro, di rivedere i luoghi sfiorati col pensiero, e magari metterli in relazione tra loro in modi che non abbiamo ancora sperimentato o misurato. Anche quando siamo all’ultima pagina, anche lì, la sensazione è quella di essere ancora all’inizio del viaggio. Perché queste storie non hanno messo a tacere la nostra curiosità, ma l’hanno ingigantita a dismisura.
Titolo: Atlante delle isole remote
Autrice: Judith Schalansky
Editore: Bompiani
Anno: 2013
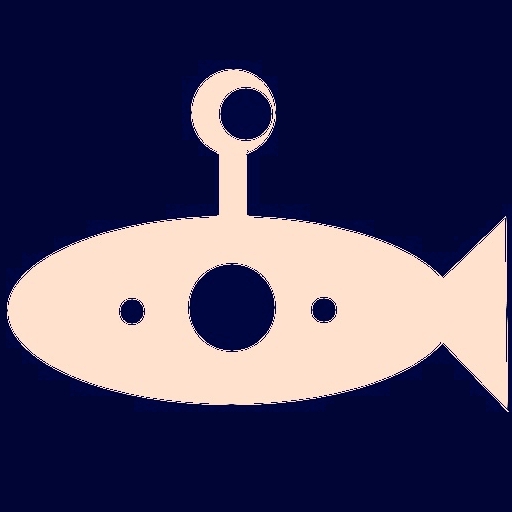 La Biblioteca di Nemo
La Biblioteca di Nemo